
Un cliente, un imprenditore, un manager, ci chiede un consiglio. Non sa come agire. Si è rivolta a noi perché lo aiutassimo a liberarsi dal dubbio che incombe su di una decisione che deve prendere.
La mia lunga esperienza professionale mi permette di mettere in evidenza due tendenze di comportamenti o modi di procedere.
La prima è quella “razionalista”. Saper fare una bella analisi del contesto, approfondimento dei dati a disposizione, acquisizione di nuovi dati se è possibile, ricerca ed elaborazione di una soluzione oggettiva.
In questo modo di operare sostanzialmente si desidera curare la malattia che determina il dubbio.
In sostanza siamo di fronte a fatti oggettivi e non ci interessa chi li ha determinati. Non ci interessano le persone che vivono quella situazione.
Dal nostro punto di vista è perfetto: “vai sulla palla e non sul giocatore” diciamo noi consulenti e formatori. Ma questo è vero quando siamo difronte ad un errore ad un fallimento. Quindi cerchiamo le cause che lo hanno determinato e non ci interessa la persona perché: tutti “possiamo sbagliare”; anzi noi consulenti diciamo spesso agli imprenditori di incoraggiare gli errori che appunto sono fonte di apprendimento.
In questo caso ci troviamo difronte ad una persona che non sa decidere. Ma noi seguendo questo modo di operare, gli costruiamo un bello schema che rappresenta la soluzione, diciamo alla persona qual è il suo ruolo e come deve comportarsi e ce ne andiamo felici e contenti. Abbiamo fatto il nostro lavoro più che professionalmente, con molta tecnica, scientificità e garanzia di successo.
Il nostro cliente “dubbioso” ha tutto quello che gli serve.
La seconda tendenza è quella “paternalista”. Ci viene esposto il dubbio e con grande decisione, fermezza e determinazione, vista la nostra grande esperienza (hanno chiamato proprio me e non altri) diamo la soluzione.
Con la prima tendenza ci abbiamo impiegato un po’ più di tempo con la seconda abbiamo fatto finta di ascoltare e capire bene ed abbiamo dato la soluzione.
In entrambi i casi “non abbiamo ascoltato” la persona che ci ha chiamati. Si. Non abbiamo ascoltato un bel nulla. In entrambi i casi abbiamo esercitato una supponenza, nel primo determinata dalla raccolta dei dati e nel secondo caso dalla nostra esperienza di guru.
Ma perché resto perplesso difronte a questi due comportamenti?
In fondo in fondo è stato chiesto di dare un consiglio per uscire da un dubbio e il lavoro è stato eseguito.
È possibile agire diversamente?
È possibile pensare che anziché risolvere il problema è possibile insegnare a come risolvere il problema?
Certo è probabile che il cliente la prossima volta sappia fare da solo e non ci chiami più. Ma cosa è più giusto fare? Qual è il comportamento più etico per un consulente?
La parola “consulère” in latino significa “sedersi accanto a qualcuno”, “stargli accanto”. Per far cosa? Per ascoltare.
Il nostro ascolto ha una qualità tutta specifica. Il nostro lavoro non parte dalla ricerca delle risposte da dare ma dalle domande da fare.
La sfida è quella di trovare la domanda che riporta le cose nella giusta prospettiva.
Non contestare ciò che il nostro cliente vede ma il punto di vista (che può essere falsato da tanti elementi) dal quale vede. Lui potrebbe non vedere la giusta via perché c’è qualcosa di rovesciato, c’è un inganno o un malinteso da qualche parte.
Ascoltare, mettere ordine e disambiguare, togliere le ambiguità presenti nella realtà del dubbioso. Se lo aiutiamo a mettere ordine allora potrà capire anche i pesi specifici delle cose che attengono al problema.
Dobbiamo tacere, far parlare la persona che ci è accanto, conoscerlo, lasciare che ci parli delle sue certezze.
Dobbiamo fare in modo che la persona metta ordine ai suoi pensieri partendo dalle sue certezze e guardando le cose da un’altra prospettiva con un bel distacco quindi con una prospettiva razionale e non emozionale.
Ma è anche possibile che il nostro cliente si sia fatto una domanda sbagliata, alla quale non sa dare risposta e ci chiede aiuto. Quindi il nostro agire potrebbe anche essere quello di fare in modo che lo scopra, se ne renda conto, e si faccia la giusta domanda, alla quale forse ha già la giusta risposta.
Da dove nasce la domanda sbagliata?
Il motivo più frequente è che le persone non sanno osservare le cose dalla giusta prospettiva e cioè non sono capaci di guardarle con distacco. E che significa? Significa guardare senza “avarizia”.
Cioè se le persone posseggono le cose ne sono attaccate (in molti casi ne sono schiave) hanno paura di perderle, queste non saranno mai capaci di guardare bene la realtà. Come possono fare una scelta se in realtà non sono libere dalle cose (materiali e immateriali) che posseggono? Se il possesso, limita la loro visione? Che domanda ne vengono fuori?
A cosa in realtà stanno cercando risposta? Per cosa ci stanno chiedendo aiuto?
È vero il dubbio al quale siamo chiamati a dare consiglio?
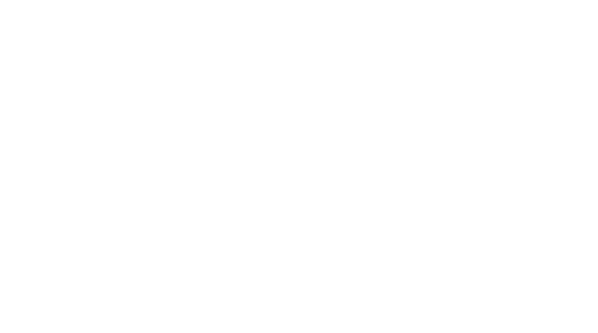


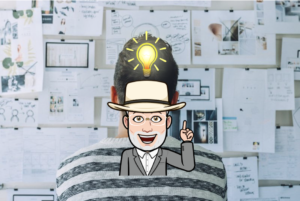
1 thought on “La professione di consigliare i dubbiosi”
Comments are closed.